Soccorso al fronte
[Racconto di Paola Manoni]
durata 17 minuti
In ogni battaglia, vinta o persa, disputata su un fronte o su quello opposto, resta sul campo la tragedia: la perdita della vita o lo stato di infermità.
I soldati italiani del 1915 affrontavano in guerra i pericoli mortali con una dotazione sanitaria costituita di un pacchetto di primo soccorso composto di qualche garza e di una fialetta di tintura di iodio.
A questo più tardi si aggiungeva una maschera con occhiali protettivi antigas la cui efficacia non era completamente garantita.
Era tutto qui, con qualche istruzione da seguire, per la minoranza che sapeva leggere perché la maggioranza delle reclute, come è noto, era composta da analfabeti.
A parte l'inefficacia delle automedicazioni, il protocollo della sanità militare italiana durante la Grande Guerra, sotto la responsabilità del Generale Della Valle, prevedeva per i soldati italiani un'organizzazione piuttosto articolata.
Il ferito veniva prelevato sulla prima linea e trasportato presso le strutture di primo soccorso poste nelle immediate vicinanze.
Queste erano determinate nella misura di una per battaglione.
Il medico di queste unità aveva una dotazione minima: garze, alcuni strumenti chirurgici di base, grappa e cognac come anestetico ed eventualmente morfina per i casi più gravi.
Qui avveniva la classificazione dei feriti, distinguendone la gravità.
Codice bianco: ferito leggero, da gestire in loco.
Codice verde: ferito grave, da trasportare all'ospedale del campo.
Codice rosso: ferito tanto grave da lasciar morire perché non trasportabile.
I feriti - trasportati a braccio, in barella, a dorso di mulo - arrivavano al campo per poi essere eventualmente trasferiti presso l'ospedale di retrovia e da qui, seguendo la gerarchia della necessità del caso, presso l'ospedale di riserva.

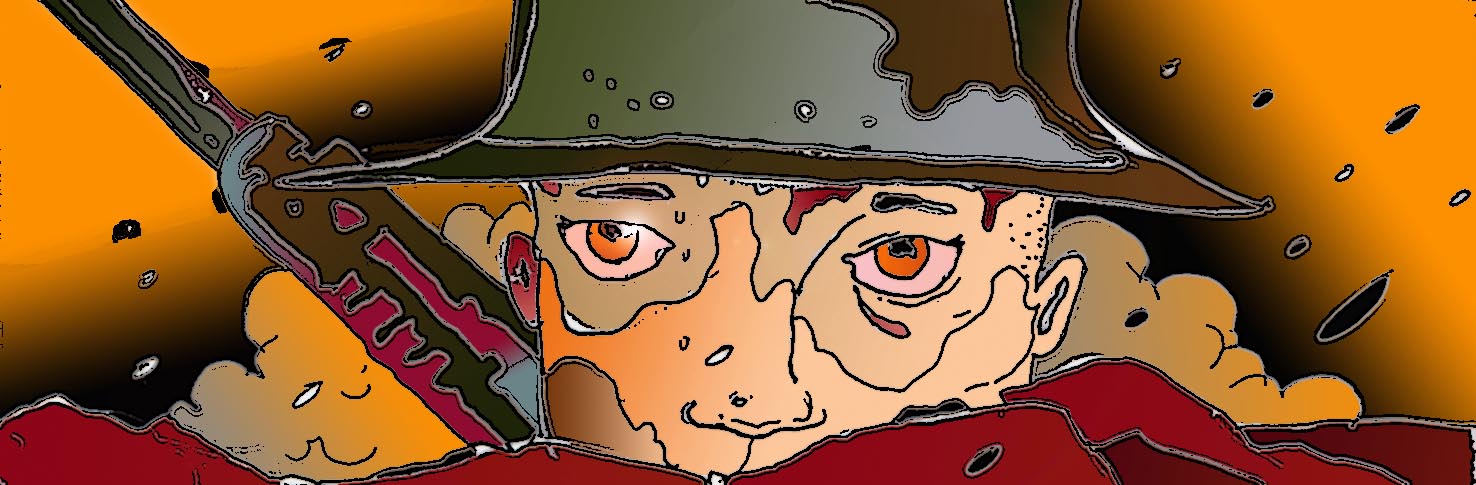










La presenza dell'annesso cimitero nell'ospedale del campo era significativo dell'esito delle prime cure, dei tentativi chirurgici approntati dai medici.
Il ferito sopravvissuto alle prime cure poteva poi raggiungere con autocarro o, nel caso più fortunato, con ambulanza gli altri ospedali per proseguire il trattamento sanitario.
I cosiddetti ospedali d'armata nelle retrovie erano dotati di sale chirurgiche, di sterilizzatrici in autoclave.
La disinfezione pre e post-operatoria era del tutto artigianale: per l'asepsi si usavano batuffoli di garza impregnati con tintura di jodio e soluzioni di acqua e alcool puro.
Artigianali erano anche le anestesie che venivano praticate con i farmaci a base di stovaina e novocaina che però agivano localmente o con l'uso di narcotici a base di etere o cloroformio, dall'alto potere tossico.
I primi apparecchi radiologici fecero il loro ingresso in queste strutture.
Vennero introdotti in Europa da volontari eccellenti come la stessa Madame Curie che aveva scoperto il radio la quale, aiutata da sua figlia (anche lei scienziata come i genitori), aveva ideato le prime unità radiologiche mobili per prestare soccorso ai soldati in guerra.
Gli ospedali di riserva gestivano la lunga degenza e le convalescenze dei feriti.
I soldati, dopo la cosiddetta visita di idoneità, a guarigione avvenuta, venivano reintegrati nei reggimenti, presso le zone di guerra oppure congedati.
Per dare un'idea: allo scoppio del conflitto (maggio 1915) vi erano in Italia solamente 70 strutture mobili di soccorso, 24.000 posti letto al fronte, 100.000 posti letto nelle retrovie e 40 ambulanze.
Questi numeri chiaramente aumentarono, ma non raggiunsero mai un'adeguata rispondenza alle necessità della guerra.
Aumentarono soprattutto i centri nei quali confluirono i traumatizzati della guerra: i nosocomi neuropsichiatrici, i centri di rieducazione per i mutilati e i sanatori per la dilagante tubercolosi nelle trincee.












Vennero istituti i treni ospedali così come le navi nelle zone adriatiche.
Furono regolamentati i reparti di sanità secondo la seguente struttura:
un tenente comandante medico chirurgo, uno o due aspiranti ufficiali quali medici subalterni, circa una trentina di militari infermieri tra cui barellieri e portaferiti.
Facevano eccezione i battaglioni di alpini, mitraglieri e bersaglieri ciclisti che avevano sezioni sanitarie autonome in grado di seguire la mobilità delle compagnie.
A questi si aggiungevano le 8000 Crocerossine volontarie che svolsero una fondamentale opera di primo soccorso, spesso ai limiti dell'impossibile.
Ma è opportuno ricordare anche i numerosi animali, perlopiù cani e muli, che hanno dato un eccezionale contributo nel ritrovamento, nel trasporto e nel traino dei feriti.
Anch'essi, per la loro parte, dei veri e propri eroi, se non martiri, di guerra.
Il destino dei feriti che non venivano lasciati agonizzanti sulla scena della battaglia era segnato dal tipo di trauma.
Le lesioni addominali, ad esempio, comportavano una mortalità praticamente certa.
I chirurghi per lo più evitavano di intervenire perché consideravano i feriti ormai perduti a causa dello shock tossico e delle emorragie a seguito delle lesioni dei grandi vasi che seguivano alla perforazione del ventre.
Solo alla fine del 1916, ove possibile, venne organizzato il trasporto di sangue per le trasfusioni (di cui però non si conoscevano le conseguenze, mancando ancora le nozioni di gruppo sanguigno e fattore RH...)
Le ferite al torace erano relativamente considerate più facili perché comportavano la mortalità soltanto del 20% circa degli operati.
Venivano estratte schegge, pallette Shrapnel e proiettili.
Tuttavia va considerata l'incidenza delle pleuriti a seguito delle ferite profonde e spesso complicate nelle tubercolosi.












Le ferite alla testa comportavano fratture, emorragie spesso dovute alle esplosioni che causavano forti compressioni craniche.
Il piombo delle armi da fuoco produceva, nel migliore dei casi, dei fori cranici passanti (di entrata e di uscita del proiettile) ma il 50% dei feriti, secondo le statistiche, era in grado di sopravvivere.
Per quanto riguarda gli arti, se non maciullati e dunque da asportare, presentavano ferite e fratture generalmente trattabili.
Le amputazioni e le disarticolazioni, se prima non sopraggiungevano sepsi e cancrena, erano la via per la risoluzione dei casi più gravi.
I mutilati furono veramente numerosi.
Alla fine del 1915 erano già un numero elevato: a Bologna venne istituita una Casa di Rieducazione professionale per mutilati e storpi di guerra il cui fine era l'integrazione sociale attraverso l'apprendimento di attività artigianali: lavorazione di oggetti in vimini e paglia, laboratori per sarti, falegnami, calzolai, legatori di libri.
Il mutilato riceveva un piccolo compenso e poi l'aiuto per un collocamento professionale dopo la dimissione dalla Casa.
Le pratiche chirurgiche necessarie per le ferite di guerra: i tentativi di chiusura dei grandi vasi e dei tendini, la ricostruzione dei tessuti diedero impulso alla ricerca, alle tecniche plastiche.
Altri problemi sanitari che affliggevano i soldati erano legati alle scarse condizioni igieniche, catastrofiche nelle trincee, che causarono diverse patologie.
Alcuni esempi sono il tifo petecchiale, caratterizzato da piccole lesioni emorragiche diffuse in tutto il corpo, oppure la cosiddetta febbre da trincea causata dagli escrementi dei pidocchi: una forma molto grave di influenza con febbre alta, di tipo periodico, e nevralgie acute che paralizzavano il soldato.
Un altro tipico male da trincea, oltre a tutte le altre infezioni causate dai parassiti che affliggevano il corpo dei soldati, era costituito dal congelamento degli arti: una serie di lesioni che nei casi più severi implicava l'amputazione.
La Grande Guerra, con l'esperienza devastante dei bombardamenti così come degli attacchi chimici, causò nei soldati dei gravissimi disturbi psicofisici, inizialmente non compresi.
Le nevrosi di guerra vennero scambiate come espedienti del soldato per disertare.
Diverse furono le fucilazioni di questi disertori, invero soldati afflitti da sintomatologia psichiatrica.
Quando si comprese che l'obnubilamento dei sensi, la perdita della congiunzione spazio-temporale, l'apatia erano indotti dagli shock subiti, si aprirono per i soldati i centri neuropsichiatrici.
Alla fine del conflitto mondiale, i grandi invalidi afflitti da sindromi da stress bellico erano considerati gli scemi di guerra non più in grado di tornare alla vita normale.
In loro albergava il delirio di persecuzione, l'amnesia, l'incapacità di sopprimere i ricordi da cui si potevano generare il mutismo, la sordità, il disinteresse del mondo esterno.
Le condizioni di estrema precarietà di vita del soldato, oltre alle nevrosi gravi, potevano sfociare nell'autolesionismo.
Questo portava il soldato a infliggersi ferite, anche gravi come ad esempio il taglio delle dita della mano.
Alcuni si iniettavano sotto la cute dei piedi l'olio di vaselina, il petrolio o l'essenza di trementina procurandosi piaghe che potevano lasciarli claudicanti per tutta la vita.
E nemmeno rare erano le causticazioni con acidi e congiuntiviti prodotte con vari mezzi irritativi (semi di ricino, infusi di tabacco, semi di lino, grani di sabbia).
Un capitolo a parte è costituito dai problemi fisici inferti dalle armi chimiche.
Queste erano sostanzialmente composte da due tipologie di gas.
I gas nervini, irritanti del sistema respiratorio, ulceranti o urticanti che causavano vomito, vertigini, mal di testa, ustioni e vesciche sulla pelle, anche attraverso i vestiti, così come cecità temporanea e dolori polmonari.
Questi effetti di elevata pericolosità non erano tuttavia permanenti.
I gas letali causavano invece la morte fulminea, bruciando l'apparato respiratorio.
E se inalati in piccole dosi, essi comportavano un'agonia soltanto più lenta.












Le prime maschere antigas, quelle che circolavano nell'esercito italiano, erano ingombranti, rudimentali e non efficienti.
Vennero poi potenziate, con l'uso di filtri e di sostanze antagoniste che contribuirono a salvare molte vite umane.
Le misure precauzionali contro i gas si estendevano ai luoghi di medicazione, fabbricati o baracche, vicini alle prime linee.
Nei casi più fortunati questi luoghi venivano provvisti di chiusure ermetiche oppure si tentava di isolare porte e finestre con coperte o teli spruzzati con soluzione di iposolfito o carbonato di sodio in grado di neutralizzare il potere venefico dei gas.
Queste stesse vaporizzazioni venivano applicate sugli individui esposti ai gas.
Per combatterne gli effetti, i posti di medicazione erano dotati di sostanze stimolanti per provocare il vomito ai pazienti.
Di utile impiego erano tè, caffé, cognac, ammoniaca, fiale di etere, di stricnina, di morfina, di caffeina e di canfora.
Gli intossicati lievi, con gas soffocanti, venivano tenuti a riposo almeno per un giorno, al riparo dal freddo, e a dieta liquida, a base di latte.
Il Vaso di Pandora rovesciato negli anni della guerra, oltre alle patologie causate dai campi di battaglia incrementò anche le grandi epidemie.
La presenza dei casini di guerra - i postriboli frequentati dai soldati - amplificò le malattie veneree.
La sifilide dilagò in tutta Europa.
All'epoca la terapia si basava essenzialmente sulla somministrazione di mercurio, ioduro o arsenico.
Il più utilizzato era comunque il primo, già noto fin dal Medio Evo ma certamente non risolutivo tant'è che la mortalità da sifilide negli anni di guerra incrementò a dismisura.
Vi fu un'altra malattia, misteriosa e tremenda, non direttamente collegata alla Guerra ma, in qualche modo, insorta nel marzo del 1918 e connessa all'ambiente bellico poiché sbarcò in Europa assieme alle truppe americane.
Fu il virus H1N1, il ceppo atavico delle moderne epidemie influenzali.
Tra gli illustri, uno dei primi colpiti fu il re di Spagna Alfonso XIII.
Per via della sua circolazione nella penisola iberica, l'influenza prese il nome di Spagnola.
Quest'epidemia uccise nel modo 40 milioni di persone di cui un milione circa in Italia: un numero di morti superiore e comparabile alle vittime della prima Guerra Mondiale.
Le sue cause, a partire dai primi 107 casi di pazienti in Kansas, rimasero un mistero.
Gli effetti mutarono il corredo genetico umano, così come le armi e le tattiche della prima guerra mondiale tracciarono i punti di non ritorno di un conflitto totale.

